

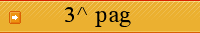
|
« Tu non sai le
colline |
|
Cesare Pavese,
da La terra e la morte 9 novembre 1945) |

Nel corso della seconda guerra mondiale,
Il movimento resistenziale -
inquadrabile storicamente nel più ampio fenomeno europeo della resistenza
all'occupazione nazista - fu caratterizzato in Italia dall'impegno unitario di
molteplici e talora opposti orientamenti politici (cattolici, comunisti, liberali, socialisti, azionisti,
monarchici,
anarchici).
I partiti animatori della Resistenza, riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale
(CLN), avrebbero più tardi costituito insieme i primi governi del
dopoguerra.
Se voi
volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate
nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono
imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per
riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché
lì è nata la nostra costituzione.
Alla
Resistenza presero parte gruppi organizzati e spontanei di diverse estrazioni
politiche, uniti nel comune intento di opporsi militarmente collaborando dove
possibile con le truppe alleate. Ne
scaturì la "guerra partigiana", conclusasi il 25 aprile
1945, quando
l'insurrezione armata proclamata dal Comitato di liberazione nazionale consentì di prendere il controllo di quasi
tutte le città del nord del paese. La
resa incondizionata dell'esercito tedesco si ebbe il 29 aprile,
anche se in alcune città come Genova le forze tedesche si erano già arrese alle
milizie partigiane nei giorni precedenti.
Per definizione, viene chiamato
"Resistenza" anche il periodo che va dagli anni trenta
alla fine della guerra, inglobando nel concetto di resistenza ogni forma di
opposizione alla dittatura di Benito
Mussolini.

Partigiani
in festa a Milano
Dopo l'omicidio del deputato
socialista Giacomo Matteotti (1924) e la decisa
assunzione di responsabilità da parte di Mussolini, l'Italia si incammina verso
un regime
dittatoriale. Il sempre maggiore controllo e le persecuzioni degli
oppositori, spinge l'opposizione ad organizzarsi in clandestinità in Italia e
all'estero, creando una rudimentale rete di collegamenti e gettando le basi per
una struttura operativa potenzialmente armabile.
Solo la guerra, e in particolare
lo sfascio dello Stato innescato dai fatti dell'estate del 1943, offre ai
clandestini l'occasione di entrare in contatto
fra loro, in ciò aiutati talvolta dalle forze angloamericane che
ne compresero la strategica importanza per le sorti del conflitto e che
provvidero ad armarle e aiutarle anche per gli aspetti logistici.
Specialmente
nel periodo dall'8 settembre 1943 (data della
proclamazione dell' armistizio e conseguente proclama Badoglio) al 25 aprile
1945 il territorio
italiano occupato dai nazisti visse una vera e propria guerra nelle retrovie.
L'azione della Resistenza italiana come guerra patriottica di liberazione
dall'occupazione tedesca, implicava anche la lotta armata contro i fascisti .

Bologna festeggia
Il 19 aprile 1945, mentre gli Alleati dilagavano nella valle del
Po, i partigiani su ordine del CLN diedero il via all'insurrezione generale.
Dalle montagne, i partigiani confluirono verso i centri urbani del Nord Italia,
occupando fabbriche, prefetture e caserme
Il 27 aprile
Mussolini, indossante la divisa di un soldato tedesco, fu catturato a Dongo, in prossimità del
confine con la Svizzera,
mentre tentava di espatriare assieme all'amante Claretta Petacci.
Riconosciuto dai partigiani, fu fatto prigioniero e giustiziato il giorno
successivo 28 aprile
a Giulino di Mezzegra, sul lago di Como.
Il 29 aprile
la resistenza italiana ebbe formalmente termine, con la resa incondizionata
dell'esercito tedesco, e i partigiani assunsero pieni poteri civili e militari.
|
Lapide ad
ignominia Piero Calamandrei, presso il Comune di Cuneo,
1952 |
Si calcola che i caduti per
Dei circa 40.000 civili deportati, per la maggior
parte per motivi politici o razziali, ne torneranno solo 4.000. Gli ebrei deportati nei lager furono più di 10.000; dei 2.000
deportati dal ghetto di Roma il 16 ottobre
'43 tornarono vivi solo in
quindici.
Furono invece 40.000 i soldati che
morirono nei lager nazisti, su un totale di circa
650.000 .
Si stima che in Italia nel periodo
intercorso tra l'8 settembre 1943 e l'aprile 1945 le forze tedesche (sia la Wehrmacht
che le SS)
e le forze della Repubblica Sociale Italiana compirono più di 400 stragi
(uccisioni con un minimo di 8 vittime), per un totale di circa 15.000 caduti
tra partigiani, simpatizzanti per la resistenza, ebrei e cittadini comuni.
Per diversi motivi molti procedimenti
giudiziari relativi a queste stragi non furono mai portati avanti, in parte a
causa di tre successive amnistie.
Solo nel 1994, durante la ricerca
di prove a carico di Erich Priebke per la strage delle Fosse Ardeatine,e per
ritorsione dopo la strage di via Rasella
a Roma, venne scoperta l'esistenza di
questi fascicoli (trovati in quello che giornalisticamente è stato definito l' Armadio
della Vergogna) e alcuni dei procedimenti furono riaperti, ad esempio
quello a carico di Theodor Saevecke, responsabile della strage di Piazzale Loreto a Milano, ove
furono fucilati per rappresaglia 15 tra partigiani ed antifascisti. La maggior
parte delle indagini e delle denunce contenute nei fascicoli non portarono
tuttavia ad un processo, poiché molti degli indagati risultarono essere non
perseguibili in quanto già morti o per l'intervenuta prescrizione
dei reati loro ascritti.
I governi espressione della Resistenza
adottarono una serie di provvedimenti per identificare i responsabili di abusi
(o presunti tali) ed efferatezze commesse negli anni di guerra. Furono creati
organi di indagine e tribunali specifici per sanzionare tali comportamenti:
erano Corti d'Assise straordinarie sotto la presidenza di un giudice di ruolo
nominato dai presidenti delle Corti d'Appello (anche Oscar Luigi Scalfaro ne fece parte). Essi
agirono con prontezza e severità, si ebbero numerose condanne a morte
(eseguite) o a lunghe pene detentive.
Alla fine della guerra di liberazione la neonata Repubblica ha
sentito l'obbligo di segnalare come degni di pubblico onore gli autori di
atti di eroismo militare (come riporta il Regio Decreto 4 novembre 1932, n.
1423 e successive modificazioni, oltre che ai singoli combattenti, anche alle
istituzioni territoriali, le Città, i Comuni, intere Regioni, Università, con
la decorazione al valor militari.